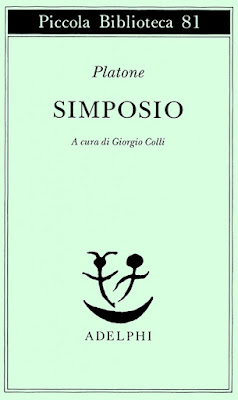Nel primo saggio, eponimo, contenuto nella "Storia dell’eternità" (1936) di Jorge Luis Borges (1899-1986) mi è balzata all’occhio un’interessantissima quanto lucida impressione dell’autore che, intento a tracciare i confini del concetto di eternità, riporta l’esempio dell’uccello. «L’abitudine di radunarsi in stormi, le piccole dimensioni, l’identità dell’aspetto, l’assidua presenza ai due crepuscoli, quello dell’inizio e quello della fine del giorno, la circostanza che frequentino più il nostro udito che la nostra vista: tutto questo ci induce ad ammettere il primato della specie e la quasi perfetta nullità degli individui», come a dire che gli animali sono segnali d’eterno. Gli uccelli che vediamo librarsi nel cielo sono gli stessi che vide Aristofane, uno smagrito cane randagio è il medesimo che curò la ferita di san Rocco, un leone che passeggia minaccioso dietro le sbarre di uno zoo sgangherato è lo stesso che entrava nell’arena del Colosseo durante i giochi romani, i pesci che vediamo scorrazzare nelle acque di un fiume sono identici a quelli riportati sul mosaico bizantino nella chiesa di san Giorgio a Madaba, che fecero dietrofront quando assaggiarono le acque salate del Mar Morto. Oggi gli animali hanno smesso di rappresentare l’eternità, poiché li abbiamo esageratamente antropomorfizzati, abbiamo traslato sulle bestie caratteristiche umane che mal si addicono alla natura ferina: affetto reciproco, capacità di discernimento, sbalzi d’umore e via dicendo. L’etologia, che intende studiare il comportamento degli animali, prende la bestia come oggetto di studio, non come individuo da psicanalizzare. L’animale umanizzato è una prerogativa del nostro tempo amorale, ascientifico, antiumano. La compassione per gli animali viene confusa coll’innalzamento dell’essere umano e un maggior grado di civilizzazione; al contrario, più essa cresce, più diminuisce quella per gli uomini nostri fratelli. Dove regna l’esaltazione della pietà animale, lì serpeggia la morte dell’eternità.
Jorge Luis Borges (1997), Storia dell’eternità, trad. di G. Guadalupi, Adelphi, Milano, pp. 135