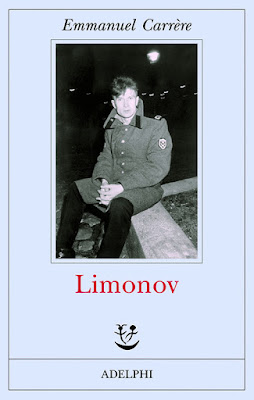Ho letto "Il pendolo di Foucault" di Umberto Eco (1932) e l’approccio filosofico del grande semiologo alessandrino bene s’inserisce nel dialogo teologico contemporaneo sull’esistenza di Dio. Penserete che contemporaneo sia un aggettivo che mal s’addice a un dibattito del genere ma siccome è nei fatti, dunque non ancora concluso, non possiamo utilizzare il termine moderno, che implica il passaggio ad una nuova epoca. Torniamo a noi. Dalla lettura del succitato libro, mi ha colpito l’unicità del punto che sostiene il pendolo, che per chi non lo sapesse rappresenta il nucleo della teoria pubblicata nel 1851 dal fisico francese Jean Bernard Léon Foucault (1819-1868) e messa in pratica nel celebre esperimento che vede un enorme pendolo abbattere dodici birilli posizionati a terra in cerchio, dimostrando definitivamente la rotazione della Terra. La grandezza dell’esperimento di Foucault non risiede tanto nella prova pratica, di per sé sbalorditiva, quanto nel fatto che il pendolo, altissimo per rendere nullo l’attrito dell’aria - assieme a dei magneti -, sia fissato al soffitto con un perno, producendo conseguentemente un dilemma pernicioso: se il pendolo dimostra la rotazione della Terra allora anche il punto al quale è agganciato ruota. Per uno che non è fisico né matematico, né tantomeno filosofo, questo potrebbe essere l’ennesimo rompicapo dell’uovo e della gallina, o del treno e del viandante (è tutta una questione di punti di riferimento, come sempre), ma i rompicapi non mi piacciono e ciò che conta sta in quell’unico punto fisso. Il motivo di tanta stupida e stupita curiosità è perlopiù spirituale; e per entrare nel mondo della spiritualità non servono lauree o dottorati, ma bisogna semplicemente liberarsi dei postulati, delle teorie e della logica raziocinante, per indirizzarsi verticalmente sulla propria esistenza ed essenza. Se assumiamo il pendolo di Foucault come l’esperimento che più di tutti prova la rotazione terrestre, prendiamo coscienza del fatto che tutti noi - ora come sempre, qui come ovunque - ci stiamo muovendo, e con noi l’intero firmamento. Invece quel punto è fermo, esso è l’unico punto fermo in tutto l’universo, è il motore immobile. La tanto agognata fonte di tutte le cose è a portata di naso, ad alcuni metri dal visitatore, in linea retta, verso l’alto, come sempre si è letto nei libri sacri e creduto nelle liturgie. Eppure il punto di quel pendolo non è l’unico, perché di pendoli sferici ce ne sono diversi nel mondo: ad esempio, io lo conobbi al Museo de las Cièncias di Valencia. Ad un livello spirituale ancor più elevato scopriamo dunque che quel punto fermo nell’universo può essere qualsiasi punto intorno a noi, possiamo essere noi. Le prove dell’inesistenza di Dio hanno sempre pagato lo scotto di cercare Dio fuori, altrove, sopra, al di là. La Chiesa, dal canto suo, L’ha sempre indagato nella Sua veste ora rituale e formale, ora grottesca e anatomica, a partire dalla dissezione dei santi. La teoria del pendolo invece sconfessa l’ateismo e conferma che il Demiurgo è ovunque. Il pensiero di Dio, al pari della rotazione terrestre, dunque, esiste: cogito ergo Deus est.
Umberto Eco (1988), Il pendolo di Foucault, Bompiani, Milano, pp. 509